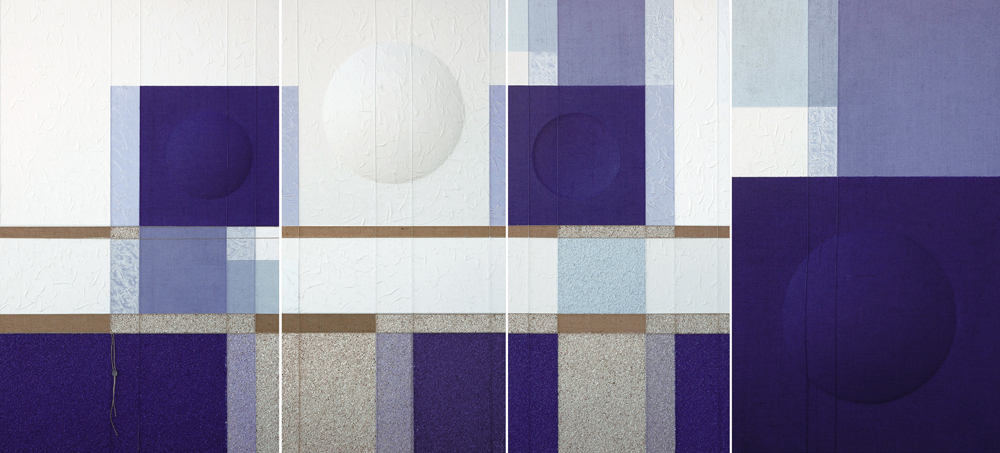
Superfici
e corde nello spazio - rapporto aureo ( Tridimensionalità Binoculare
nella NUOVA VISIONE SPAZIALE)
Tecnica
mista su juta e multistrato, 2011, cm120 x 268
Riflessione
sulla “nuova visione spaziale” di
Saverio Magno
L’opera di Saverio Magno si inserisce nel novero di esperienze
estetiche novecentesche derivate dall’osservazione dello spazio
fisico, un’interpretazione scientifica incline alla realizzazione
di lavori in cui lo spettatore possa verificare il mistero nascosto
della percezione visiva. La “nuova visione spaziale”, come
egli stesso l’ha definita, fa riferimento a una linea iconografica
che dal Cubismo di Braque e Picasso giunge diritto allo Spazialismo
di Fontana, passando attraverso elementi di Neoplasticismo derivati
da Mondrian. Un percorso ben preciso dove l’artista, applicando
il concetto astronomico della parallasse stellare, origina un sistema
visivo in cui la pittura abbandona i semplici valori bidimensionali
per inserirsi in contesti tridimensionali restituendo, allo spettatore,
l’esatta condizione visiva della realtà.
La ricerca di Magno si sviluppa in tre fasi conseguenziali: una prima
legata alla diretta presa di coscienza del suo lavoro (da parte dello
spettatore) attraverso l’utilizzo di strutture cubiche, il cui
impiego ricorda le camere ottiche del XVII secolo; una seconda in cui
l’opera, il dipinto, si separa da tali strutture acquisendo autonomia
espressiva; una terza, infine, in cui l’artista restituisce quella
che può essere considerata la raffigurazione di una vera e
propria visione 3D.
Questi tre passaggi consentono di comprendere tale indagine orientata
sostanzialmente nella possibilità di conferire, attraverso l’arte,
la reale visione del mondo legata alla nostra percezione binoculare.
Dal punto di vista estetico si è difronte a un artista profondamente
tecnico la cui ricerca è da accostare non solo ai nomi già individuati,
ma anche ad artisti che nella storia hanno espresso inclinazioni similmente
orientate alla restituzione analitica degli elementi reali. Si pensi
ad esempio ad un Canaletto e al lavoro che proprio con la camera ottica
quest’ultimo ha portato avanti, oppure ai francesi Seurat e Signac,
la cui ricerca si basava totalmente nelle coeve teorie di ottica, così come
Cézanne che già nelle sue opere tentava la restituzione
binoculare della linea di contorno, per arrivare poi ai futuristi
e alle teorie di percezione ottica nelle compenetrazioni iridescenti
di Giacomo Balla.
Nel caso di Saverio Magno, tuttavia, la questione si fa ancor più complessa,
poiché l’artista unisce la ricerca ottica alla questione,
come detto, della parallasse stellare permettendoci di verificare una
condizione di relazione tra l’essere terrestre e il rapporto
con lo spazio cosmico. Questo passaggio è definito dall’artista
nella sua “nuova visione spaziale” come un punto d’approdo
verso una consapevolezza nuova. Se è vero che Fontana, per la
prima volta, attraverso il taglio sulla tela tentava di sondare il
mistero ignoto dell’Universo, ma di fatto annullando la pratica
pittorica, nella nuova visione spaziale di Magno il problema non si
fonda tanto su questioni filosofiche, piuttosto intercetta una sorta
di neorealismo visivo dove l’elemento contingente si sintetizza
nella forma pura e in un insieme di velature finalizzate a permetterci
un’esatta comprensione dello spazio circostante.
Questa proiezione visiva ed estetica del reale ci induce ad una riflessione
sulla nostra percezione della vita. L’aniconicità di Magno
appare perciò in linea con le teorie neoplasticiste e spazialiste,
trovando una possibile congiunzione semantica e stilistica nell’insistenza
sulle forme rigide ortogonali e sui colori primari: rosso, giallo e
blu. A ciò va altresì unito quel riferimento tridimensionale
che sondando la dimensione ottica del vero finisce per suggerire nuove
possibili condizioni percettive dell’intera esistenza. Il lavoro
di Saverio Magno attiene infatti ad elementi prossimi all’architettura
poiché inevitabilmente orientati a trasportare lo spettatore
entro spazi d’interazione totale.
Ad una prima vista le opere esprimono principi di astrattismo tradizionali,
ma addentrandoci nell’insieme del lavoro si comprende come questa
sia solo la superficie. La complessità degli elementi in gioco
va infatti ricondotta al tentativo di superare la bidimensionalità per
addentrarsi nel mistero dello spazio tridimensionale. La doppia visione
di cui egli parla si materializza nelle attente velature e in un insieme
di linee e corde che determinano la costruzione spaziale in relazione
al nostro punto di vista. Ciò determina continui spostamenti
delle superfici visive nonostante la fissità dell’osservatore,
ma soprattutto spinge ad una riflessione ancora più ardimentosa:
la questione del nostro rapporto con la realtà cosmica.
Ogni artista visivo si colloca, di fatto, in quello spazio intermedio
tra la realtà e il nostro modo di percepirla. La nuova idea
spaziale di Saverio Magno si palesa altresì in una direzione
che – ma è solo una mia personale ipotesi – richiama
certe suggestioni derivanti dalle teorie della fisica più recente.
Mi riferisco, ovvero, all’idea che l’Universo non sia in
realtà tridimensionale, ma olografico e sostanzialmente in
due dimensioni. Secondo tali teorie sarebbe la nostra percezione
a decifrare
le tre dimensioni, ma in chiave sostanzialmente ingannevole rispetto
alla vera natura del Cosmo.
Queste teorie non cambiano la nostra vita quotidiana, ovviamente,
ma inducono noi osservatori a definire rinnovati scenari esistenziali.
Parallelamente il lavoro di Saverio Magno, mi sembra di poter dire,
intercetta una nuova dimensione esistenziale della realtà superando
le vecchie convenzioni. Se vogliamo quindi definire la sua “nuova
visione spaziale”, siamo dunque indirizzati a vederla come un’inedita
possibilità di linguaggio aniconico che unisce pittura, scultura
e architettura, ma che si materializza solo attraverso la visione dello
spettatore il quale diviene parte integrante dell’opera.
Un pensiero complesso che diventa arte nel momento in cui abbandona
l’esclusività della ricerca teorica, per incanalarsi nella
condizione estetica. In alcuni casi i quadri vengono affiancati per
poi essere uniti in un’unica grande opera. Questa azione consente
all’artista di rappresentare la tridimensionalità binoculare
e la visione 3D. La teoria consiste dunque nella proposta di scindere
le due traiettorie visive, cioè quella di sinistra e di destra,
facendole convergere in un’unica focale prospettica deducendone
che l’occhio sinistro guarda l’immagine destra, mentre
il destro quella sinistra. Collocando un oggetto a metà della
distanza tra gli occhi e i due quadri ne emerge infine l’immagine
di tre elementi manifestando, nello spostamento dell’oggetto
avanti o indietro, la percezione della tridimensionalità.
Da questi esercizi di metodo resta a noi la bellezza di opere essenziali
e minimaliste, la cui natura compositiva rimanda al rigore neoplastico,
ma arricchito da suggestioni spazialiste e cadenzate sottilmente
tra materia e colore. Il fondo bianco, nella maggior parte dei casi,
concorre
a donarne leggerezza e purezza collocandole nel ristretto ambito
delle ricerche contemporanee più raffinate e dal grande valore
artistico.
Andrea Baffoni
